ECONOMIA DELLA CONOSCENZA PER LIBERARE IL LAVORO, di Paolo Borioni, da LeRagioni.it, 19 gennaio
09 febbraio 2011
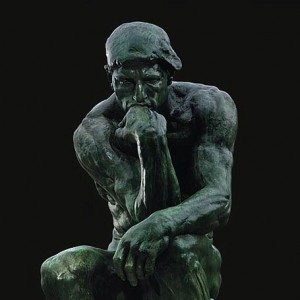
intervento al convegno “I socialisti nell’Europa in crisi-The social democratic forces in the Europe in crisis” organizzato da Le Nuove Ragioni del Socialismo e dalla Fondazione Ebert
Il modo in cui il concetto di “economia della conoscenza” è stato interpretato in Europa risente grandemente del contesto degli anni 1990, in cui ha ricevuto applicazione politica. Il contesto è quello della prevalenza di governi europei socialdemocratici fra 1995 e 2005. Tale prevalenza, a sua volta, fu largamente determinata dal fatto che la revisione dei modelli sociali europei intrapresa dalla fine degli anni Settanta (in direzione sostanzialmente neo-liberale) aveva raggiunto un suo limite di difficile valicabilità. La difficile valicabilità corrispondeva ad alcuni tratti strutturali del modo europeo di fare mercato, società ed economia, sostanzialmente diversi da quelli Usa. Negli Usa vige quello che definirei il concetto di “land of opportunities”. Esso consiste in una sconfinata importazione di capitali (grazie alla forza del dollaro), di persone e di competenze dall’estero. Senza questo modello di conoscenza e di capitale importato sarebbe stata inconcepibile la sylicon valley, con l’enorme contributo fornitole dai “nuovi americani”. Esso rende di converso possibile che amplissimi strati di popolazione residente vengano poco o nulla valorizzati come “capitale umano”. E anche resi relativamente inoffensivi nel condizionare le scelte che presiedono a questo stato di cose. A tale inoffensività concorrono la bassissima sindacalizzazione, la modesta partecipazione elettorale, il modello partitico e di primarie apertamente e larghissimamentemente plutocratici. Ma anche il fatto che quanto appena detto conduce ad un rinnovamento bassissimo nel ceto politico eletto. Tutti fenomeni che limitano ad alcuni ceti centrali la ricerca del consenso, ignorando grossomodo il restante 50% della popolazione con teorico diritto di voto. Di ciò è elemento connaturato il welfare residuale, che è particolarmente tale riguardo alle politiche del lavoro.
Il modello sociale europeo, che nella struttura di lunga durata si basa su importazione di capitali, individui e conoscenza molto minore, è invece portato, in tutte le sfere suddette (dalla politica, alla sindacalizzazione, al welfare, all’istruzione pubblica e gratuita di buona o ottima qualità, compreso, a voler leggere bene i dati il nostro paese) ad includere la popolazione con cittadinanza. Prendendo a prestito un’espressione (non a caso) svedese, possiamo chiamare questo modello Folkhem, casa del popolo. Secondo tale modello la popolazione va inclusa sostanzialmente nella sua totalità nei benefici suddetti che, a loro volta, divengono un modo di concepire e condizionare il capitalismo.
In parte nelle isole britanniche a progressiva finanziarizzazione neoliberale post-Thatcher si offriva un terzo modello che forniva una propria soluzione mista per cui mentre alcuni dati di spesa pubblica (da welfare) non si discostavano dalla tradizione europea, tuttavia ciò avveniva nel contesto di una dissociazione fra tali dati e un loro diretto impiego nel plasmare mercato del lavoro e produzione. L’impatto particolarmente ingente della cultura neoliberale nel Regno Unito, cioè, concepiva il Welfare come qualcosa che sta “intorno” alle esigenze del capitale. Un dispositivo “morale” e “comunitario” giustapposto, al limite proprio per permettere un dispiegamento moralmente e socialmente insindacabile del capitalismo. Anche gli innegabili investimenti dell’epoca di Blair nel welfare state possono essere intepretati in questo modo. Ci torneremo fra poco.
Quanto detto finora serve ad individuare correttamente alcuni nodi problematici ed alcune analisi riguardo al rapporto fra socialdemocrazia, welfare e società della conoscenza. Le socialdemocrazie hanno, negli anni 1990, interpretato il mandato loro attribuito nel senso di una richiesta di mantenimento/aggiornamento dei modi strutturali del competere e produrre europeo (in cui il welfare è inclusivo nel mercato e condizionante del mercato) coniugandoli però con una serie di nuovi dati. Uno di questi era proprio la società/economia della conoscenza. Emergevano ovviamente anche altri dati nuovi e centrali (l’Euro, la globalizzazione proveniente ora da nuove zone del mondo, la fine del blocco dell’Est), ma era comunque la corrispondenza fra modello sociale europeo ed economia della conoscenza il nodo centrale anche rispetto alle altre novità. Ciò perché proprio una valuta forte, la fine delle svalutazioni competitive e le nuove realtà industriali globali dovevano condurre ad individuare al meglio (e a tradurre in politiche) quella corrispondenza. Infatti, tanto più la presenza e la concezione del welfare era del tipo che garantiva una condizione di sostanziale parità fra lavoro e capitale (e tanto più, poi, il welfare estendeva tale parità sia nel territorio del mercato del lavoro sia in quello della più ampia società) tanto più la via della competizione tramite vasti investimenti in conoscenza diffusa diveniva inevitabile.
Cosa ci dicono infatti i dati? Essi ci dicono che quei paesi in cui la socialdemocrazia negli anni 1990 poteva contare su di un forte apparato di “parità” fra lavoro a capitale hanno anche investito di più in conoscenza. I fondamenti della parità sono welfare universalistico, welfare assicurativo sindacale, forti sindacati, forte prassi di economia negoziata: tutti aspetti interconnessi che permettono di evitare in gran parte la competizione sui bassi salari. Tutti aspetti, quindi, che implicano un condizionamento virtuoso dell’investimento e della strategia produttiva, e ciò sia in paesi in cui sono presenti grandi aziende strategiche (la Svezia, la Finlandia, l’Olanda, ma in qualche modo anche la Francia) sia in altri, in cui queste non si trovano (la Danimarca). Si parla di investimenti nel complesso intorno al 5% del Pil o superiori. Ciò che possiamo constatare, infatti, è che i governi di centrosinistra degli anni 1990-2000 ad avere ottenuto maggiore successo nella società della conoscenza sono proprio quelli che hanno condizionato il capitalismo ad investire molto in politiche attive del lavoro e nell’innovazione, concedendo relativamente poco verso la competizione da bassi salari e flessibilità “cattiva”. In coda a questa classifica ci sono quei Paesi europei come l’Italia e il Regno Unito, che per ragioni diverse sono mediocri investitori sia in ricerca e innovazione (che produce la conoscenza) sia in politiche attive del lavoro (che la diffondono nel processo produttivo). Va peraltro puntualizzata una cosa: le politiche attive del lavoro non sono semplice “formazione di base” (non sono la solamente la enunciata “education, education, education” di Blair). Esse sono molto di più poiché rafforzano ulteriormente la parità fra capitale e lavoro in quanto: si collocano in uno degli ambiti cruciali in cui lavoro e capitale si confrontano: la determinazione delle competenze rispetto alle strategie produttive, sostenendo implicitamente l’importanza di una determinazione socio-politica (non assolutisticamente “padronale”) della competitività; ri-legittimano (perché ri-funzionalizzano) il welfare contro la disoccupazione, cioè uno dei pilastri della stessa “parità”.
Ed eccoci ad un primo specifico socialista e socialdemocratico della questione. Quanto detto ci dice delle cose precise sul capitalismo: se non si difende il lavoro, il capitalismo è sempre abbastanza miope da condurre a strategie competitive riduttive e depressive (Italia, con l’attuale proposta di Marchionne come esempio principe), oppure a veri e propri disastri (isole britanniche). L’Italia, da parte sua, deve ricostruire un sistema di innovazione, un tempo notevole, dopo che la divisione di compiti fra Pmi e grande industria (flessibilità dalle prime, investimenti di lungo periodo dalle seconde) è stata distrutta: vedasi il disinvestimento produttivo strategico della grande industria privata e la ideologica criminalizzazione dell’industria pubblica. Nell’ambito britannico si è, invece, semplicemente perseguito tutt’altro: una crescita finanziaria e debitoria dissennata, demolendo invece il circuito occupazione-produzione-salari in maniera molto più esplicita che altrove. Ben poco a che vedere con la società della conoscenza. Ed infatti gli anni di Blair registrano una sproporzione immensa fra investimento finanziario (850 miliardi di sterline) e investimento direttamente produttivo manifatturiero (50).
Sia chiaro: se è essenziale predisporre gli strumenti della parità capitale-lavoro come una sorta di “limite condizionante” invalicabile, bisogna però prestare attenzione a non assolutizzarne l’autosufficienza.
Ed è qui che tocchiamo un secondo punto socialdemocratico e socialista della questione che ci aiuta, ideologicamente ed euristicamente, a comprendere tutto il resto. Come hanno bene messo in luce alcuni studiosi nordici, la società della conoscenza è stata, specie nella sua interpretazione blairiana veicolo di un notevole travisamento. Per i blairiani, in sostanza, società della conoscenza significava fine della dialettica di interessi fra capitale e lavoro. Semplicemente, cioè, si identificavano capitale e conoscenza, per cui, distribuendo quest’ultima, si aboliva pressoché ogni differenza tra chi aveva ANCHE il capitale e chi aveva solo la conoscenza. Per alcuni cioè, la società della conoscenza realizzava il maggiore compito della socialdemocrazia: liberare il lavoro conferendogli un tipo nuovo di parità con il capitale. A differenza di quanto affermano alcuni scarsi o devianti interpreti italiani, tutta la “terza via”, a cominciare da Giddens, ha inteso questo come un nuovo esito socialdemocratico, giammai come la fine della socialdemocrazia. Abbiamo visto sopra, in ogni modo, quanto ne fosse errato l’assunto principale. Senza un disegno socio-politico atto a co-determinare (non a lasciar fare) il capitalismo nell’agire, non si realizzava parità né conoscenza, ma marginalizzazione del lavoro. Con corredo di crescita drogata o modestissima.
Nei documenti e soprattutto nel modo di interpretare la propria funzione i socialdemocratici nordici hanno invece continuato a concepire la società in termini tripartiti. Ovvero a distinguere chi aveva conoscenza a capitale, chi aveva conoscenza, e chi non aveva nessuna delle due. Solo un sistema che tenesse conto delle differenze di interessi potenziali fra le tre condizioni, e che bilanciasse (a favore del lavoro) la differenza di potere fra di essi, poteva condizionare le strategie di investimento in senso positivo.
Tuttavia, paradossalmente, le due strategie avevano qualcosa in comune, ossia la rinazionalizzazione delle politiche. Infatti, sia il disegno finanziario-debitorio di Blair, sia il modello socio-produttivo dei nordici sono stati concepiti (fatto tipico di Paesi euro-scettici) in modo autosufficiente rispetto ad una strategia di investimento e crescita europea. Così, alla lunga, la dipendenza di ogni Paese europeo dagli altri ha portato (tanto più con la crisi) anche i nordici a una crescita troppo lenta ed incerta rispetto agli investimenti sociali di cui abbiamo detto. Per questo motivo le destre liberal-conservatrici e populiste nordiche hanno potuto riproporre uno schema che mette sotto accusa le alte spese derivanti dai meccanismi di welfare della “parità”. Anziché risorsa della competizione nell’economia della conoscenza e di rifiuto dei bassi salari, quindi, esso viene presentato come un incentivo troppo esteso e costoso al non-lavoro.
E’ necessaria, anche più drammaticamente che negli anni 1990 una strategia europea che riporti al centro un ciclo concertato di investimento-innovazione-salari-welfare capace di una crescita affidabile e di lungo periodo. Nouriel Rubini, ad esempio, propone che si favorisca un temporaneo indebolimento dell’Euro seguito da un taglio delle tasse e ad una crescita dei salari in Germania, così da poter ristabilizzare l’economia Ue grazie ad uno sviluppo politicamente determinato, ovvero senza ulteriori tagli al modello sociale europeo. In seguito, anche per l’ormai ottenuta crescita del mercato interno, l’Euro potrà anche riapprezzarsi (per la tranquillità dei tedeschi). Gerald Holtham indica invece la disponibilità di grandi risorse potenziali per titoli europei da trasformare in generale stabilizzazione del debito dei Paesi membri. Ma anche in massiccio investimento innovativo. Perché, come detto, c’è una terza lezione socialdemocratica da trarre dalle vicende dell’economia della conoscenza: la capitalizzazione del sociale tramite la diffusione di apprendimento continuo e ricerca è un ottimo presupposto. Ma la capitalizzazione del sociale ha pur sempre bisogno di un certo grado di “socializzazione del capitale”, intesa come determinazione democratica e negoziata dell’investimento produttivo.
